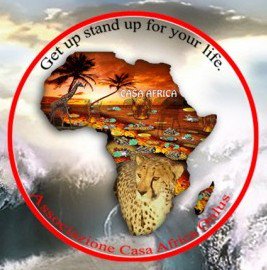Con i profughi Afgani
 In uno di quei pigri pomeriggi domenicali, in cui guidare per gli stradoni deserti di Roma può risultare perfino una cosa rilassante, sono arrivato con molto comodo, un po’ in ritardo. Sulla via Ostiense, al numero 182, c’è un’insegna che, incastrata tra quelle dei pub e delle sale di slot machine, appare quasi aliena: “Comunità Cristiana di base di San Paolo”. Da lì si entra in una grande sala polifunzionale, che ho trovato già ricolma di persone, di cui, per le mie scarsissime conoscenze etnografiche, avrei potuto solamente dire che erano “più o meno tutte dello stesso colore”. Si tratta in realtà di una comunità di profughi afgani, che hanno chiesto l’asilo politico in Italia. Tutti uomini, o meglio, ragazzi. L’età media sembra tra i venti e trent’anni. Arrivati in Italia nei modi più disparati, drammatici, per sfuggire al regime dei Talebani; viaggiando nei bagni delle navi, dentro le celle frigorifere o addirittura appesi sotto ai camion.
In uno di quei pigri pomeriggi domenicali, in cui guidare per gli stradoni deserti di Roma può risultare perfino una cosa rilassante, sono arrivato con molto comodo, un po’ in ritardo. Sulla via Ostiense, al numero 182, c’è un’insegna che, incastrata tra quelle dei pub e delle sale di slot machine, appare quasi aliena: “Comunità Cristiana di base di San Paolo”. Da lì si entra in una grande sala polifunzionale, che ho trovato già ricolma di persone, di cui, per le mie scarsissime conoscenze etnografiche, avrei potuto solamente dire che erano “più o meno tutte dello stesso colore”. Si tratta in realtà di una comunità di profughi afgani, che hanno chiesto l’asilo politico in Italia. Tutti uomini, o meglio, ragazzi. L’età media sembra tra i venti e trent’anni. Arrivati in Italia nei modi più disparati, drammatici, per sfuggire al regime dei Talebani; viaggiando nei bagni delle navi, dentro le celle frigorifere o addirittura appesi sotto ai camion.
Mi colpiscono i loro sorrisi e la loro apparente normalità. In fondo sembra di stare in un enorme bar dello sport di provincia, la domenica pomeriggio. Anche loro indossano sneakers, blue jeans, giubbotti imbottiti. Passano il tempo giocando a carte o ipnotizzandosi davanti ai cellulari; ascoltano musica orientale, mangiano semini, bevono il thè. Uno ogni tanto si siede a strimpellare un pianoforte. Ma mi chiedo quale sia la loro vita al di fuori di quella sala, dove dormono, come passano le giornate.
La comunità cristiana gli mette a disposizione quello spazio tre volte a settimana, acquistando il cibo necessario per la preparazione della cena. Io non sono un gran cuoco, cucino molto di rado. Appena arrivato mi assegnano un compito apparentemente semplice, ma per cui ben presto mi scopro inadeguato: affettare le carote. Si sta parlando di una cena per cento persone, e le carote sono un gran mucchio. Uno dei ragazzi afgani in cucina mi fa vedere come si fa. Vanno tagliate sottili sottili, quasi trasparenti. Lui deve essere un cuoco, è molto abile: afferra una carota premendola sul tagliere con la mano sinistra chiusa, a mo’ di zampa di gatto, e con il coltello sulla destra la affetta con rapidissimi colpi che passano a pochi millimetri dalle sue dita. Ci provo anch’io, ma non riesco a tener ferma la carota allo stesso modo, e quel coltello che nelle sue mani sembrava un’arma micidiale, nelle mie non taglia affatto. Impiego un quarto d’ora per ottenere lo stesso numero di fettine di carota che lui avrebbe prodotto in un minuto, e per di più le mie sono grandi come tronchi. Pertanto, decido di concentrare le mie attività nella zona cessi.
Ci sono due gabinetti a un lato della grande sala, di cui uno con la doccia. Molti ragazzi ne approfittano per darsi una ripulita. Ogni tanto a qualcuno serve dello shampoo, un asciugamano, un rasoio, e io glieli porto. Arriva anche uno con una cresta alla El Shaarawy (il giocatore del Milan) e mi chiede del gel per capelli. No, quello non ce l’abbiamo. Insomma, trascorro buona parte del pomeriggio lì, seduto di fianco al gabinetto, a soddisfare questo tipo di richieste. È facile, mi metto in pace la coscienza dopo la brutta figura con le carote, i ragazzi sono tutti educati e simpatici.
Intanto arrivano Antonella, che è la signora organizzatrice dell’evento, e Marta, un’altra volontaria di Roma Altruista. L’ora della cena si avvicina, dalla cucina iniziano a provenire odori forti. La sala si sta riempiendo, ormai ci sarà più di un centinaio di persone. Aiuto a disporre i lunghi tavoli di legno e le sedie, le tovaglie e i fazzoletti di carta.
Alla fine, nella sala vengono trasportati grossi pentoloni fumanti, contenenti riso con verdure e spezzatino di carne con patate, fagioli e cavolfiori. Più alcune focaccine simili alla pitta che si mangia in Grecia e Turchia. Da bere, caraffe di acqua riempite dalla cucina. Prima di mangiare però Antonella deve fargli il discorsetto. Ha un piglio da organizzatrice, sa bene che per coordinare certe attività occorre anche un po’ di durezza. Rimprovera quelli che hanno versato il thè e i semi di girasole per terra senza pulire, e poi chiede cinque di loro che si offrano per riordinare al termine della cena. La platea è restia, le mani non si alzano, ma finché non si trovano i cinque, non si inizia a mangiare.
Trovati i volontari, non senza fatica, Antonella dà l’ok: che la cena abbia inizio. C’è una specie di boato prodotto dalle sedie, quando i ragazzi si alzano per andare a mettersi in fila davanti ai pentoloni. Un’altra decina di persone arriva giusto in tempo per mangiare. La cena dura un lampo se confrontata con la lunga preparazione pomeridiana. La sala è presto disseminata di piatti unti e salviette appallottolate. Offrono anche a me un po’ di spezzatino. Lo assaggio, è molto speziato, onestamente non mi piace. Rimaniamo solo io, Marta, Antonella, e i cinque volontari a rimettere a posto i tavoli, pulire la sala, spazzare e dare lo straccio. Si accendono le luci al neon. È notte, comincio a pensare al lunedì, alla settimana che inizia, a tutte le preoccupazioni superflue che neppure il contatto con persone molto più inguaiate di me mi ha fatto passare.
Ma almeno, questo pomeriggio ho aiutato a dar da mangiare a cento profughi afghani. Come direbbe Carver, è una cosa piccola, ma buona.
Moreno, 38 anni, Roma